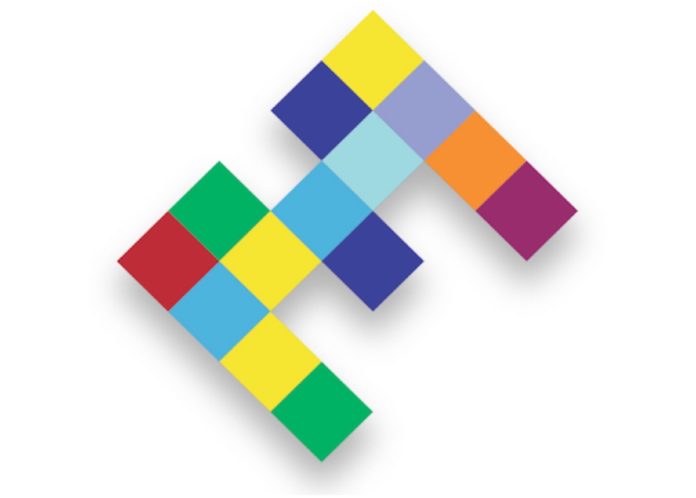Gli americani, si sa, amano il business e molti da quelle parti giocano in Borsa, come tossici. È un residuo dell’etica protestante e dello spirito del capitalismo, per parafrasare Max Weber. Si riflette nell’epoca dell’informazione perfetta, quella che scorre in rete senza alcun attrito, senza lacuna barriera, senza alcun ritardo. Si riflette nelle prospettive esistenziali, nelle viste panoramiche sul futuro, che estrapolano tendenze per i prossimi cinque, dieci, cento anni sulla base di indicatori che cambiano ogni giorno, alle volte più volte al giorno.
Facebook in quattordici anni è molto cambiato, non solo cresciuto. Il social media (questo il termine che definisce l’attività delle aziende come Facebook, e non social network, visto che la “rete sociale” esiste da sempre, da quando gli esseri umani hanno cominciato a frequentarsi e a parlare tra loro) creato da Mark Zuckerberg è più grande che mai, più forte che mai, più chiacchierato che mai, e più in crisi che mai. Perché?
Se volete celebrare l’epopea americana di come un ragazzo bianco di origine europea ha creato una gigantesca multinazionale della pubblicità che “succhia” le informazioni sulle persone, da queste peraltro offerte volontariamente (è questo il genio dell’operazione) e le rivende al miglior offerente, oppure che vende spazi per influenzarle con bolle di informazioni fatte circolare (a pagamento) sui “muri” e attorno ai profili delle persone, allora guardatevi il film girato qualche anno fa (nel 2010) da David Fincher su sceneggiatura di Aaron Sorkin intitolato The Social Network. O magari leggetevi The Circle di Dave Eggers. Insomma, documentatevi, perché non è quello il succo della storia.
Il succo della storia invece sono i numeri: nel 2016 Facebook aveva una capitalizzazione di mercato di 434 miliardi di dollari, e il 97% del suo fatturato (28 miliardi) derivava dalla pubblicità. Alphabet, cioè Google, aveva una capitalizzazione di mercato di 651 miliardi e l’88% del suo fatturato (90 miliardi) derivava dalla pubblicità. Microsoft invece con 536 miliardi di capitalizzazione di mercato e un fatturato di 85 miliardi aveva il 7% del suo fatturato dalla divisione advertising, e Apple con 804 miliardi di capitalizzazione e 216 di fatturato non aveva (e non ha) neanche una voce dedicata alla pubblicità: 5% di altri prodotti e 11% di servizi sono il massimo che si riesca ad estrapolare dal bilancio.
Tutto questo per dire che Facebook, come e più di Google, è un gigante completamente in equilibrio su uno spillo: quello dell’attenzione delle persone. La sua è una vera economia dell’attenzione. Il suo lavoro è paradossalmente molto simile rispetto a quello del motore di ricerca di Google: prevedere i desideri e le ricerche dei suoi utenti e proporre in anticipo, tramite l’algoritmo che seleziona le cose da mettere sul muro delle persone, i contenuti generati dagli altri o dagli altri condivisi.
In un paese come l’Italia, che si è incagnito per alcuni giorni attorno a una notizia che non lo era (il brevetto del braccialetto di Amazon, come abbiamo raccontato anche su queste colonne digitali), parlare di strategie, prospettive, ipotesi di sviluppo, conseguenze di scelte, è quasi inutile. Facebook si celebra come tormentone, è il posto dove i giornalisti vanno a prendere le foto (sbagliate) delle vittime degli incidenti ferroviari, dove si parla e si sparla degli amici, dove le coppie che si separano bloccano i rispettivi profili e gli “amici” e le “amiche” spargono fiele e fango, fango e fiele, dove si mettono infinite foto di altre persone, ad esempio figli e nipoti, martellando la vita di tutto il roster dei propri conoscenti e si condividono sempre le stesse quattro cose sfigate perché, se è vero che è stato dimostrato matematicamente che chiunque su Facebook è a molto meno di sei gradi di separazione da chiunque altro, è anche vero che si condividono le solite quattro stupidaggini, senza pietà.
Criticare Facebook vuol dire non aver capito però la bravura strategica e la capacità di cambiare pelle come un serpente, quando è arrivata l’era dei telefonini: perché Facebook è una delle pochissime aziende consolidate che è riuscita a migrare dal web per desktop all’app per mobile senza colpo ferire e anzi, totalizzando il suo maggior successo di crescita.
È gestita da un padre-padrone completamente inadatto alla vita sociale, che studia cinese e che gira la vite degli algoritmi che fanno comparire o non più comparire gli articoli dei giornali, creature ingenue che hanno pensato di poter trovare in Facebook e in Zuckerberg il salvatore e soprattutto il diffusore della loro importantissima, imprescindibile merce: quell’informazione, spesso tarocca o mal fatta, che non riesce neanche più ad attirare click, sconfitta da infinite legioni di neonati, di gattini, di video ripresi in verticale da qualche telefonino chissà dove o chissà di chi. Una memoria digitale paurosa che ci perseguiterà per i secoli e, contemporaneamente, scomparirà in pochi attimi.
Facebook ci è sicuramente amico, anche perché ha saputo ridefinire il termine “amico” provocando un decennio di polemiche, di critiche, di tentativi di rivoluzionare quell’idea di legame debole che diventa totalizzante, forte, continuo e costante. Se quella parola, “amico”, adesso significa quel che Facebook vuole che significhi, sicuramente siamo (quasi) tutti amici di Facebook. È stata una trasformazione che invece la forza del dollaro e del pettegolezzo continui del mondo digitale sono riuscite a imporre nella coscienza e nella vita di ciascuno di noi.
Poi ci sono quelli che non sono su Facebook, poi ci sono quelli che se ne sono andati, poi ci sono le generazioni che su Facebook non fanno più cose perché comunque non gli piace e ci sono altre persone che invece non voglion vedere: ogni tanto si discute se Facebook sia un posto da giovani o da vecchi, da figli o da genitori, e i dubbi sono molti e si moltiplicano. Ma alla fine i numeri aggregati non lasciano scampo: Facebook è il grande posto dove in tanti siamo prigionieri, ogni giorno, di una mente arredata all’Ikea, sempre con gli stessi pezzetti tutti uguali per tutti, ricordi che sono interscambiabili, bambini identici, selfie identici, identità indistinguibili perché massificate dal minimo banale comune multiplo. Una uniformità paurosa e potentissima, che Facebook da quattordici anni persegue con logica e pervicace energia.
Tanti auguri, Facebook. E grazie per tutto quello che di bello hai portato nelle nostre vite.