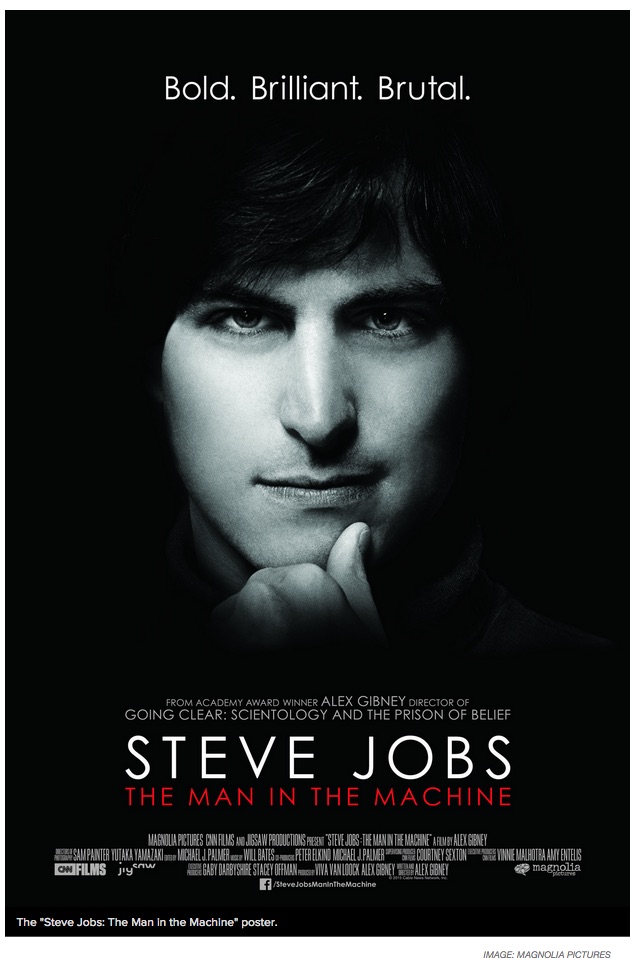Ken Segall, il creative advertising director che tante volte ha lavorato a stretto contatto con Steve Jobs e uno degli artefici della resurrezione della Apple, ha avuto modo di guardare “Steve Jobs: The Man In The Machine“, controverso documentario di Alex Gibney. Il suo verdetto, lo dice subito, è: “Doppio pollice in giù”. Non ha gradito la visione al punto di dire: “Vorrei avere più pollici per poterli mettere giù”, “non lo odio perché è denigratorio – non sono neanche sicuro se lo è – è un vagare senza meta tra gli aspetti positivi e negativi di Jobs”. Il pubblicitario dice che il documentario gli sembra mal concepito e diretto, ed è sorpreso da ciò considerando la qualità del precedente lavoro di Gibney, Going Clear, su Scientology.
“La differenza è che Going Clear esplora un soggetto oscuro per molti e si basa su un libro ben approfondito; The Man In The Machine non lo è; è una semplice rimasticatura di cose già note su Jobs, presentate come se fossero novità”.
“Buona parte del mondo ha già pesato luci e ombre della vita di Steve e giunta a una conclusione: sappiamo che l’uomo non era un santo ma anche che aveva una visione e sì, anche una personalità, che gli hanno consentito di arrivare a risultati straordinari”.
“Se Gibney avesse portato un po’ di nuova luce su questo argomento, il documentario avrebbe potuto avere un valore, ma non l’ha fatto e non ce n’è traccia”; “Cue ripete storie trite e ritrite: la sua disonestà con Woz, il suo inizialmente negare la paternità, il giocare sporco con il suo pacchetto azionario, lo sfruttamento dei lavoratori cinesi, ecc.”. “Sono annoiato nel riscrivere ancora queste cose” dice Segall. “Gibney aveva promesso di rivelare il lato oscuro di Steve, ma le prove sono per lo più inconsistenti”.
Ha fatto sentire la voce di Yukari Kane, autore di “Haunted Empire” (libro dello scorso anno che prospettava un futuro fosco per la Apple del dopo Jobs) parlando di argomenti quali il circolare con un’auto senza targa (il defunto CEO sfruttava una lacuna della motorizzazione che concede sei mesi di tempo per apporre la “license plate” ai veicoli di nuova immatricolazione), e la sua abitudine a parcheggiare alla Apple nei posti riservati ai portatori di handicap, due argomenti presentati per dimostrare che “era al di sopra della legge”.
Segall prosegue costatando che, oltre a voler arrampicarsi sugli specchi, il documentario di Gibney presenta anche errori tecnici e inesattezze varie. Gli iMac colorati sono, ad esempio, presentati come i primi iMac (non è vero, giacché il primo iMac era il Bondi blu). Si evidenziano anche ricostruzioni errate quando parla del noto spot Crazy One, dicendo che Steve era così colpito dall’annuncio commissionato da volere una versione con la sua voce; Segall spiega ancora una volta che all’epoca dovettero insistere nell’usare la sua voce e che Jobs non la riteneva adatta, che questa potesse distrarre il pubblico; su insistenza dell’agenzia fu effettivamente registrata una variante con la sua voce, ma Jobs non acconsenti a mandarla in onda.
“Nel complesso” dice Segall, “il film sembra alla ricerca dell’inquietante, evidenziandolo in elementi dove non ha neanche senso”. A un certo punto si parla dell’iPhone come di una tecnologia per certi versi quasi emarginata da Jobs (chiunque conosce un minimo di storia della Mela sa bene che non è così). Ci si lamenta del poco essere statunitense della Apple, società che sfrutta meccanismi per pagare le tasse al minimo e fa profitti su prodotti realizzati all’estero. Si insinua nello spettatore l’idea che Apple dovrebbe essere rinnegata dagli USA, dimenticando che questa non fa altro che comportarsi alla stregua di tutte le altre aziende tecnologiche presenti nella classifica Fortune 500.
Parlando dei suicidi alla Foxconn, si mostra il caso di un lavoratore accusato di avere contrabbandato il prototipo di un iPhone fuori da una fabbrica, dipingendo il ritratto di un uomo ingiustamente accusato al punto da costringerlo al suicidio. Gibney pronuncia cose assurde, del tipo: “Se Jobs avesse davvero pensato diversamente, non avrebbe dovuto preoccuparsi di più delle persone che toccano gli iPhone prima che questi arrivino nelle mani degli utenti?”.
Segall conclude la sua stroncatura a tutto tondo del documentario parlando di “una noiosa accozzaglia di storie già sentite da cui non viene fuori nulla”.