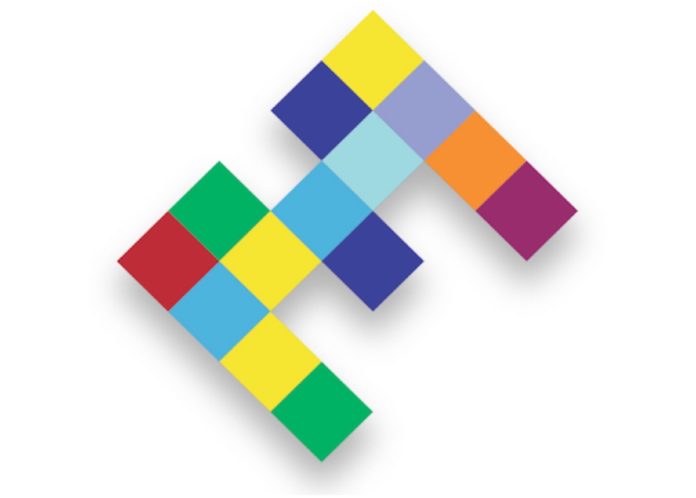La prima parte, la seconda parte e la terza parte del nostro viaggio nel mondo dei videogiochi
Il negozio si estende per quattro piani di una sconclusionata palazzina due strade dentro il cuore di Akihabara. La nozione di “piano” è fuorviante, perché ciascun livello del palazzo è poco più di uno stanzone, stretto e lungo. Ma l’affollamento di mirabilia del mondo del gioco è straordinario. Strette scale permettono di entrare all’interno di SuperPotato, uno degli infiniti paradisi degli amanti del video game. Le commesse giapponesi, due ragazze sui vent’anni (per quanto sia possibile attribuire un’età a volti asiatici che paiono in maggioranza aver stretto un patto col demonio per cancellare il passare del tempo sino al penultimo stadio dell’invecchiamento), sono indaffarate dietro un bancone saturato di gadget e pubblicità : telefonano, mandano qualche messaggio con i loro cellulari senza equivalente in Occidente, ridono di tanto in tanto di scherzi incomprensibili. La sala è divisa da due imponenti scaffalature centrali che creano tre corridoi più stretti di quelli di un Boeing 767, mentre la larghezza complessiva è al massimo di cinque metri. Nei dieci metri di profondità della stanza, però, sono sei le pareti esposte a scaffalatura sino al soffitto.
Qui inizia la magia. Nintendo Entertainment System e Super Entertainment, ma con i nomi originali di Famicon e Super Famicon. E poi, scaffalate e scaffalate (tutte di legno chiaro, forse betulla) di giochi per console portatile: GameBoy, ma anche esotiche (per l’Europa) console portatili di Sega, Bandai e Snk. Poi, angoli pieni di giochi per Saturn, Dreamcast, Playstation 1, Nintendo 64, altre marche difficili da identificare, ricordi che si sovrappongo, sovraccarico di emozioni che – come scintille trasmesse lungo il cavo dei nervi a velocità troppo elevata – hanno il sapore di informazioni che non ammettono distrazioni: pochi secondi, il battito delle ciglia e un’intera sezione della storia del videogame come non è mai stata raccontata da nessuno dei libri che fioriscono soprattutto nel mercato americano scompare in un attimo, perduta per sempre.
Si chiama “sinestesia” lo stato della mente ma anche la figura retorica che accomuna due esperienze sensoriali come fossero una sola. E camminare nei metri quadri del terzo piano di SuperPotato, per quanto sia cheap il nome (e perché no? dopotutto questa è Akihabara, la città elettrica) porta in un attimo, in un flash di sinestesia, il sapore di quel pomeriggio da adolescenti che si entrò nel cinema per vedere il primo Ghostbusters, o di quella volta che si apriva la confezione di quel gioco un po’ legnoso per Atari e pixel quadrati grandi come mosche disegnavano sul fondo del tubo catodico ipotetici asteroidi o forse la silouhette di un finto Indiana Jones mentre con una rudimentale liana saltava i trabocchetti e pitfalls pieni di coccodrilli.
Scartabellando tra i mucchi di console e accessori, emergono Dreamcast a trenta euro, Nintendo 64 avvolti nella plastica come melanzane a cinque euro. I giochi, congelati nell’arido silicio delle cartucce o nel vischioso polimero che bacia le lamelle argentate dei cd, parlano a neuroni che si pensavano oramai perduti di ricordi lontani, fasti e tripudi per giochi esotici, successi trionfali e straordinarie rivoluzioni. à il vero mondo in diretta, il canale che, carotando l’anima, riporta l’uomo all’adolescente lontano e creduto morto o forse perduto per sempre ma in realtà ancora palpitante.
Uno degli aspetti più paradossali dell’industria culturale contemporanea è lo sforzo costante di riesumare la memoria dei più-che-trentenni, impacchettarla e rivenderla come un surgelato qualsiasi del supermercato. In realtà , forse alienati dalla situazione sociale e politica dell’Italia contemporanea, l’unica terapia d’urto è un viaggio verso il Giappone. Basta prendere la linea Yamanote del servizio di treni di superficie della JR East (una delle quattro entità rimaste dopo la privatizzazione e scorporo delle Japan Railways) e scendere verso est, tre click dopo lo zenith del cerchio che la linea descrive attraverso i quartieri di Tokyo: Akihabara, soprannominata un po’ pomposamente “la città elettrica” ma che noi potremmo ascrivere allo stato dello spirito descritto dal “paradiso della brucola”: la città dei monomaniaci dello spirito e anche della materia.
Akihabara tratta tutto quello che nessuna ragazza vorrebbe mai trovarsi davanti: dai saldatori alle resistenze, dagli obiettivi per fotocamera alle lampade Lcd, dai memorabilia del silicio ai video game. Forse si riescono anche a fare degli ottimi affari, ma di sicuro si riesce a viaggiare attraverso un catalogo esauriente di parte delle ossessioni della gioventù moderna. Abbastanza per cominciare a comprendere qualcosa dell’anima dei moderni giapponesi metropolitani ma soprattutto molto della storia dei videogiochi.
Per qualche strana combinazione, infatti, dentro Akihabara rimangono incastrati i relitti di molti dei giochi e dei videogiochi della storia delle console. Solo le edizioni giapponesi, ovviamente (come se ne esistessero altri di importanti). E SuperPotato è uno dei migliori e dei più importanti tra queste celle frigorifere della storia del gioco. Mantiene tracce del passato, mostra evidenze del presente, predice il futuro. Forse non è un caso se le sinapsi sovraccariche portano alla mente il sapore di un film alquanto generazionale come Ghostbusters: era interpretato fra gli altri da quel Bill Murray che diciannove anni dopo, nel 2003, ha aiutato Sofia Coppola a portare a casa Lost in Translation, l’epica bonsai dell’incomunicabilità all’interno di due universi avvolti l’uno nell’altro.
Se non lo trovate da SuperPotato, allora i casi sono due: non esiste oppure è veramente troppo vecchio. E per vecchio, entrando nel piano dove un Odyssey della Magnavox guarda benigno l’ignoranza delle giovani generazioni, si intende il pleistocene. Cullati da questo stordimento lisergico sotto forma di bit plastificati, quello stato innaturale dell’informatica che avrebbe saputo dare tante soddisfazioni alla metafisica classica se solo l’avesse potuto conoscere, una mano scivola verso uno scaffale, toccando un’Età della Storia. à il tardo tramonto del Dreamcast, punito per l’eccessiva “ubris” di aver proposto una console da 128 bit in un momento in cui il mercato aveva solo bisogno di concretezza e in cui i predatori carnivori di Sony stavano cambiando radicalmente le regole del gioco (e all’orizzonte si avvicinava la balena bianca di Microsoft). L’avevano chiamata “progetto Katana” tra gli altri (chi non ricorda White Belt e poi Black Belt, oppure Shark?), era raccontata come la migliore, la più potente, l’infinita. E, in effetti, nonostante fosse nata nel lontano 1998, ancora oggi potrebbe far vedere qualcosa di serio a Playstation 2 e a Microsoft Xbox. Un solo gioco, forse, è riuscito realmente a sfruttarne la potenza dei suoi processori: si tratta di Soul Calibur, il sequel di Soul Edge per Playstation poi ripreso sia nel mondo delle console che in quello degli arcade da Namco.
Si potrebbe scrivere un poema per Soul Calibur: fu uno dei giochi di lancio del Dreamcast e, nonostante l’ostica disposizione logica della struttura dei comandi del suo processore, il migliore fin da subito. C’è chi lo considera il miglior gioco di combattimenti di sempre, e forse non ha torto. La cosa imbarazzante per gli amanti del genere è che a tutt’oggi, accedendo un Dreamcast sfuggito alle debolezze della cinghia della sua ottica incaricata di scorrere al di sotto del Gd-Rom, si possono provare ebrezze e definizioni in competizione con i migliori fra i giochi di ultima generazione. Un inedito e improvviso revival del Dreamcast sta rifiorendo in questi mesi, avverte una sensazione che scivola come una corrente elettrica a basso voltaggio attraverso il metallo di Akihabara: i giochi sviluppati per la console ufficialmente “morta” nel marzo del 2001, i giochi vengono ancora venduti online in Giappone e titoli nuovi sviluppati da terze parti fanno la loro comparsa sugli scaffali di Akihabara. C’è chi parla di un rilancio della console, mentre siti web anche Occidentali, come l’americana IGN, hanno deciso di riaprire la loro sezione dedicata alla vetusta console e ri-recensire i vecchi capolavori aprendo le porte delle percezione ai nuovi titoli che si stanno cominciando a fare avanti.
Akihabara è anche questo: il posto dov’è possibile assistere allo sforzo di una comunità polverizzata di individui che perseguono le loro ossessioni private, i loro sogni maniacali, le loro passioni allucinate e riescono qualche volta a tramutare i sogni in realtà e le realtà in sogni. Il Dreamcast, per il quale si susseguono le pubblicazioni dei titoli e per il quale la stessa Sega ha deciso – in Giappone – di riaprire gratuitamente i server di Phantasy Star Online (bisognerebbe anche riprocurarsi il costoso e ingombrante modem a 57Kb/ps della console… anche se i server europei sono stati uccisi da Sega lo scorso 1 aprile 2007), dato per sepolto oltre che morto rimette invece una mano fuori dal suo avello e cerca di nuovo la luce.
Lo spirito del video game è potente, in Giappone, e la sua ricchezza supera le barriere delle diverse culture. Anche se all’apparenza non è così: le due commesse di SuperPotato, interpellate con un marcato accento e nessuna formula di cortesia appropriata, nella ricerca di soddisfazione per un’ossessione nell’ossessione, ammettono con secchezza di non possedere più alcun controller esterno realizzato su misura da Taito per Densha de Go 2 Ex. La freddezza della risposta ad una domanda che per un attimo si teme impropria e fuori luogo sta per lasciare il sapore amaro della disillusione e dello scoramento, unito al fantasma sempre presente dell’incomunicabilità : forse era una domanda fuori luogo, forse era posta con troppa maleducazione, forse era sbagliato qualcosa d’altro, l’ineffabile della cultura giapponese. Ma, con lo sguardo già basso mentre ci si volta per uscire, un’appendice di risposta all’improvviso illumina la scena: “Non ti preoccupare, però, Gai-ko-ku-jin, perché forse la prossima settimana rientra”. Si riaccendono due fiamme di speranza: da un lato forse rientrerà e dall’altro l’appellativo, Gai-ko-ku-jin, straniero, e non Gai-jin, barbaro ignorante. Questa volta l’anima delle parole non è andata persa nella traduzione.
La prima parte, la seconda parte e la terza parte del nostro viaggio nel mondo dei videogiochi