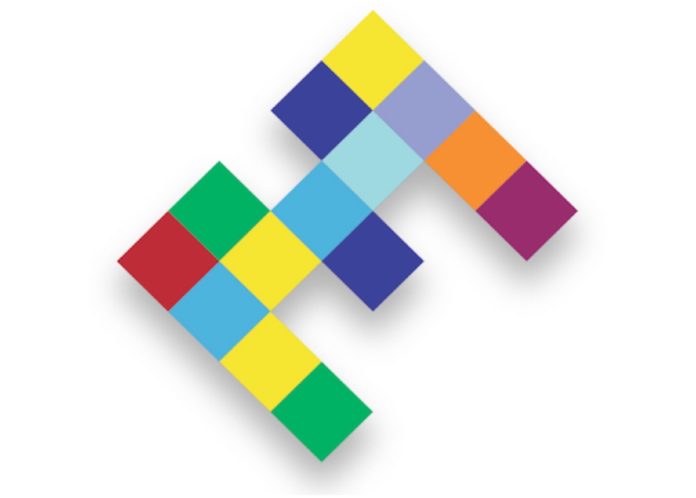[banner]…[/banner]
Come un Grande fratello. Anzi, come un servizio qualità, che fa attenzione e, anche se non lo sai, ti guarda, ti ascolta, prende nota, si dà da fare, ma silenziosamente.
Se c’è una cosa che si capisce da questa WWDC è che Apple è tutt’altra che distratta, lontana, chiusa nella sua torre eburnea. Tutt’altro. È nella valle di noi peccatori, utenti o sviluppatori che sia, e vuole cercare di lenire le nostre sofferenze, migliorando le cose. Anche per i cambi di direzione strategica più spettacolari. Ma ricapitoliamo i fatti.
Apple è stata l’epitome dell’azienda a misura del suo utente. Costruita “per il resto di noi”. Pensata per darci quel che volevamo, prima ancora che sapessimo di volerlo. Ha giocato la carta del pubblico professionale e di quello della scuola, due mercati in cui è sempre stata oggettivamente forte, sia nei momenti di buona che in quelli di crisi. Poi, nel 1998, con iMac prima, iPod dopo (2001) e quindi con iPhone (2007) e iPad (2010) ha aperto con grande decisione il fronte del pubblico di massa, indistinto, incapace di notare anche solo la presenza dell’adesivo della mela morsicata nella striminzita busta delle istruzioni/garanzie.
Apple è diventato un marchio da indossare, esibire, sfruttare, far funzionare. E negli ultimi due o tre anni ha cominciato ad abbandonare uno dei suoi due mercati di riferimento. Non quello scolastico (dove anzi è sempre più presente) ma quello degli sviluppatori professionali, dei creativi, dei digital bandits, dei nomadi digitali.
Anche la presentazione dello scorso ottobre, con i nuovi MacBook Pro super costosi e meno potenti del solito ha aperto una drammatica ferita nella psiche tormentata dei creativi digitali di tutto il pianeta. Circondati da due assedi contemporanei: da una parte Windows 10 e Google, con proposte allettanti di strumenti per la creatività in fasce di prezzo diverse e contraddittorie, con prodotti diversi e contraddittori. Dall’altra i nuovi prodotti, immaginati per un pubblico di casual user sempre più esibizionisti, alla ricerca della mela da mostrare più che dello strumento superiore per fare il proprio lavoro con gioia.
Perché, se è vero come è vero che il lavoro ci definisce, per molti di noi il computer è l’aratro e la vanga, il camion e il tornio, la scrivania e l’ufficio. È il posto dove si lavora, anche se siamo in un bar, nel soggiorno o in cucina, nell’ufficio di qualcun altro, su un treno o su un aereo. E lo strumento ci può migliorare, potenziare, rallegrare, rendere la vita migliore e più bella, oppure triste e misera, difficile, faticosa, stancante.
Una intera leva di creativi digitali (usiamo sempre questa locuzione per mancanza di espressioni migliori) ha protestato, si è strappata capelli (se poteva) e vesti (se voleva). Ha protestato, urlato, riempito forum su forum di commenti arrabbiati, tristi, abbandonati, solitari, devastati. Tutte le fasi dell’elaborazione del lutto. Nel silenzio di Apple.
Invece no, Apple ha ascoltato. Come una divinità primitiva, uno spirito delle cose che anima gli oggetti e la natura attorno a noi, popolando le ombre e le luci improvvise, il tuono e la pioggia ma anche il sole e i ruscelli scintillanti, Apple ci ha accolto e avvolto tutti, fino a partorire… Beh, quasi partorire: diciamo che ha mostrato una line-up di prodotti che è un’ecografia di cosa sta succedendo.
Potenziamento dei MacBook sia Air che normale che Pro, iMac tosti e da combattimento, iMac Pro mai visto prima un desktop all-in-one così, e promesse di un futuro migliore. Apple ha ascoltato. E gli sviluppatori, il popolo alfa dei creativi digitali e padri e madri di tutto quello che segue (a cominciare dalle app e dai servizi di terze parti) sono contenti. Molto contenti.
Anche in rete, dove da ormai qualche anno cova una negatività in parte artefatta e prezzolata probabilmente da concorrenza sempre più sleale, ma in parte anche frutto di un reale disagio, l’onda ha cambiato decisamente verso. Rimane una stampa generalista come sempre pigra e particolarmente succube degli umori del pubblico, al quale propina solo cinismo e disincanto, che si è espresso ignorando o meglio cercando punti deboli. Uno tra i più risibili attacchi ai prodotti e tecnologie presentati lunedì è relativo al costo dell’iMac Pro.
Critica più che sensata se solo chi la scrive avesse idea di cosa sta parlando. Se l’iMac Pro fosse un computer per giovani smanettoni, appassionati di videogiochi, con budget striminziti da universitari o liceali, allora certo, costerebbe un botto. Sarebbe come fare un iPhone da tremila euro, un MacBook Air da 2900.
Peccato che sia un computer “Pro” (si capiva anche dal nome? Ma va?) con un processore Intel Xeon che da solo costa quasi un terzo del prezzo della macchina e che comunque serve per scopo professionale su workstation. La demo di realtà virtuale è stata fatta dai maghi di Industrial Light and Magic non con un gioco ma con il software che serve a costruire le animazioni dei film di Hollywood. E non i film di serie C, ma la serie di Guerre Stellari. Film con budget da 100–200 milioni di dollari, che vengono lavorati per due anni, dove spendere duecento, trencentomila dollari di workstation per poter avere un vantaggio di qualche mese nei tempi di produzione è considerato un vantaggio competitivo che ripaga di almeno un paio di ordini di grandezza.
Certo, per i nostri leoni da tastiera queste sono cose difficili da immaginare: il loro piccolo mondo antico ruota attorno al loro Pc con Photoshop craccato e al client di Gnutella pieno di spyware verminoso come il sacchetto del pescatore quando esce di casa al mattino presto, prima ancora che sorga il sole. In quella prospettiva, per giocare a Call of Duty per PC scaricato da BitTorrent con Wine effettivamente cinquemila euro di iMac Pro sono un filo troppo (e Metal 2 manco funziona). Ma si sa, quelli di Apple non hanno mai capito niente di queste cose. O forse è merito di chi prende una chitarra elettrica e ci vuole giocare a tennis, lamentandosi perché non si qualifica per il Roland Garros?